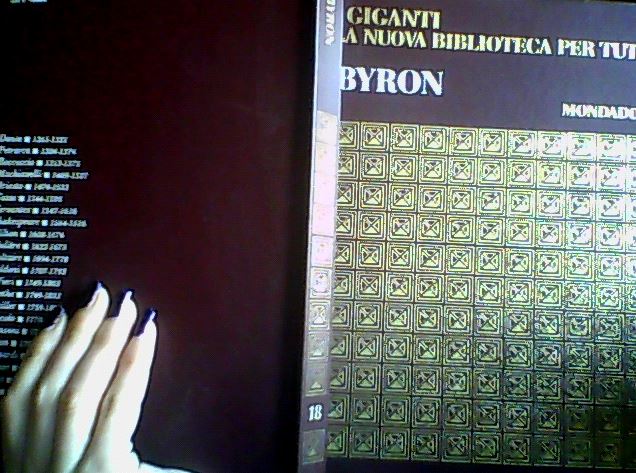COMMENTO AL "MANFREDI"
Il "Poema Dialogato Manfedi" ("Manfred") è l'opera più rappresentativa della crisi spirituale in cui Byron si dibatte nell'estate del 1816 all'inizio del suo esilio. L'anelito alla pace e all'oblio, il peso di un oscuro rimorso, il distacco da una società che si avverte estranea e ingiusta, la riscoperta delle consolanti bellezze della natura costituiscono le note dominanti dell'opera e le conferiscono, pur nella cornice fantastica e sovrannaturale che le è propria, un carattere autobiografico.
Il "Manfredi" (pubblicato nel 1817) è scritto in versi endecasillabi sciolti: si divide in atti e scene, ma non è un dramma; fu l'autore stesso che rifiutò questo nome: "dovete chiamarlo poema non un dramma... un poema dialogato o pantomima se più vi piace o qualunque altro nome purché non sia sinonimo di teatro". Effettivamente, Byron aveva ragione: l'opera non ha nulla di teatrale, sebbene qualcuno abbia tentato di portarlo sulle scene. La trama è semplice e lineare. Manfredi invoca con i più potenti incantesimi gli spiriti della terra, dell'aria, delle acque, della notte e della sua propria stella per ottenere da essi il sospirato oblio. Gli spiriti obbediscono al richiamo ma non è in loro potere di esaudirlo. Uno di essi, dopo avergli vanamente offerto, insieme agli altri, ricchezze, dominio, lunga vita, si materializza ai suoi occhi assumendo l'aspetto di una deliziosa fanciulla. Manfredi, soggiogato, muove ad abbracciarla, ma essa gli sfugge come ombra vana; e l'uomo deluso s'abbandona privo di sensi al suolo.
Fallito l'incontro con gli spiriti, Manfredi s'arrampica fino alla vetta della Jungfau, per cercare tregua al suo tormento nello splendore e nella pace del paesaggio alpino; ma invano. Ossessionato da tentazioni di suicidio, sta per precipitare da una rupe; ma è salvato da un cacciatore di camosci che gli giunge alle spalle inaspettato. Continua il suo disperato andare, finché sul bordo di una spumeggiante cascata, evoca la Maga delle Alpi. A questo "spirito del luogo" Manfredi accenna alcune linee della sua storia: la giovinezza fiera e selvaggia, gli studi appassionati, la brama di scrutare il mistero della vita, e infine, il suo funesto amore per una giovinetta legata a lui da vincoli di sangue e rimasta poi vittima della sua passione. Ma la maga, per aiutarlo, reclama una promessa di assoluta obbedienza; e il ribelle Manfredi non si sente di accettare. Rimasto solo dopo un cupo intermezzo dove l'apparizione delle tre Parche prepara l'ingresso delle divinità delle tenebre, Manfredi si presenta al trono di Arimane, il genio del Male, per implorarlo che sia evocato lo spettro di Astarte, la donna da lui amata. Essa viene; ma alle sue ansiosi domande e implorazioni oppone un cruccioso silenzio. Soltanto alla fine si lascia sfuggire il nome di lui e una promessa: l'indomani vedrà la fine dei suoi tormenti. Nel terzo atto, la luce soave del crepuscolo prelude all'imminente fine di Manfredi. L'abate di san Maurizio, impensierito dalle voci che corrono sulle sue pratiche di magia nera, si reca a vederlo, per salvarne l'anima. Ma Manfredi ricusa il conforto della religione: sente il suo destino prossimo a compiersi e poi si richiude nella torre dove ha vegliato tante notti, scrutando i segreti della natura e del mondo invisibile. Ma l'abate non cessa le sue esortazioni. Ma anche gli spiriti del male reclamano l'anima di Manfredi: egli risponde con orgoglio che non hanno potere sulla mente: essa è immortale e basta da sé a punirsi o ad esaltarsi (*). L'ultimo gesto è per l'abate, un debole tocco della mano e per lui sono anche le ultime parole: "Vecchio! Non è così difficile morire!".
Nell'Ottocento il "Manfredi" ispirò vari musicisti: da Schumann che compose un poema sinfonico nel 1850 a Ciajkovski che ne prese lo spunto per un'ammirevole sinfonia.
Il personaggio di Manfredi, il castellano-mago che domanda alle scienze occulte il dono dell'oblio e la tregua al rimorso che lo divora, è uno dei più strani e inquietanti che siano usciti dalla penna di Byron. Nacque in una stagione tormentosa del suo spirito; in molti punti, ricorda Faust. (http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/08/introduzione-goethe.html)
Vi furono anche polemiche al momento della pubblicazione, tra i critici che pretendevano che il personaggio byroniano derivasse dal Dottor Faust di Goethe, e l'autore negava risoluto: "il diavolo se li prenda tutti e due i Faust, l'inglese e il tedesco! Io non ho preso né l'uno né l'altro", scriveva all'editore. E in verità il Manfredi ha una sua spiccata originalità (Nota di Lunaria: infatti io preferisco "Manfredi" al "Faust" goethiano).
Le coincidenze tra i due personaggi sono soprattutto esteriori: Faust è un personaggio tormentato dai problemi che in ogni tempo si sono posti all'umanità pensante: per penetrare il mistero dell'eterno contrasto tra l'ideale e il reale, fra la carne e lo spirito egli è pronto a vendere al demonio la propria anima. Manfredi invece non ricerca, come Faust, la conoscenza, ma l'oblio. Da una parte abbiamo la tragedia di una mente che vuole valicare i limiti del sapere umano ed è disposta a pagare un prezzo esorbitante, dall'altra, invece, vi è uno spirito tormentato dalla coscienza di un oscuro delitto che domanda alle arti magiche l'oblio ma ricusa di accettare la signoria delle forze del male: persino al cospetto di Arimane, il "genio delle tenebre", il suo atteggiamento è di orgoglio e sfida. Alle esortazioni degli spiriti: "Curvati a terra e adora, o schiavo! Trema e obbedisci! O se no, temi il peggio", Manfredi risponde: "Lo so, eppure vedete che non mi prosterno". Del pari, il suo nero pessimismo è in contrasto con l'ottimismo di Faust: invecchiato sui libri, anela a tornare giovane, l'ardore di vivere non è spento in questo vecchio che vuole ritrovare la perduta gioventù. Al contrario Manfredi è vecchio nello spirito, non spera più nulla.
Commento di M. Praz a Byron:
"Per altri grandi scrittori la vita conta assai meno, si può, in certi casi, persino ignorare, ma per Byron la poesia non ne era che uno degli aspetti, e i suoi cimeli hanno un valore poetico la cui suggestione è talora più potente di quella di molte sue poesie (...) Byron è un'atmosfera, un clima, una disposizione di spirito, più che un verso o un determinato gruppo di versi. Si esclama "Byron!", dinanzi a una situazione, a un contrasto di passioni, a un'uscita sarcastica o ironica come in "Werther" gli innamorati, dinanzi a un particolare aspetto della natura, esclamavano "Klopstock!" (...) Byron è qui sentito come umore, come particolare temperie dello spirito, più che come poeta; in verità, quando pensiamo a Byron, la prima cosa che ci si offre dinanzi agli occhi è una presenza fisica, un profilo. Con quanti poeti ci capita lo stesso? Non molti, direi. Forse che vediamo Petrarca leggendone i sonetti? Ma Byron, ecco un'evocazione istantanea, prepotente: quel profilo fatale, quel mento risentito, quelle curve labbra, quelle palpebre leggermente abbassate sullo sguardo orgoglioso, quei capelli elegantemente scomposti, e l'apollineo collo emergente dalla camicia aperta. Byron lo vediamo ancora come lo videro le donne sue contemporanee, le quali, chi più chi meno, sognarono di lui."
(*) Nota di Lunaria: citazione non solo ispirata da Milton, ma anche da Schiller. Infatti:
" [...] Strappata dal Peloro, o dal fianco squarciato/dell'Etna che rintrona, le viscere sempre nutrite/di combustibile e pronte a concepire fuoco/sublimato di furia minerale porgono aiuto ai venti/e lasciano un fondale abbruciacchiato, ravvolto/di fumo e di fetore: simil era il terreno sul quale/posavano le piante dei piedi maledetti. Lo seguiva il compagno più prossimo, entrambi gloriandosi/di essere sfuggiti al gorgo dello Stige/simili a Dei, recuperate ormai tutte le forze,/e non perché era il potere più alto ad averlo voluto./"è questa la regione, è questo il suolo e il clima"/disse allora l'Arcangelo perduto, "è questa sede che/abbiamo guadagnato contro il cielo, questo dolente buio/contro la luce celestiale? Ebbene, sia pure così/se ora colui che è sovrano può dire e decidere/che cosa sia il giusto: e più lontani siamo/da lui e meglio è, da lui che ci uguagliava per ragione/e che la forza ha ormai reso supremo/sopra i suoi uguali. Addio, campi felici/dove la gioia regna eternamente! E a voi salute, orrori,/mondo infernale; e tu, profondissimo inferno, ricevi/il nuovo possidente: uno che tempi o luoghi/mai potranno mutare la sua mente. La mente è il proprio luogo,/e può in sé fare un cielo dell'inferno, un inferno del cielo./Che cosa importa dove, se rimango me stesso; e che altro/dovrei essere allora se non tutto, e inferiore soltanto a lui/che il tuono ha reso il più potente? Qui almeno /saremo liberi; poichè l'Altissimo non ha edificato/questo luogo per poi dovercelo anche invidiare,/non ne saremo cacciati: vi regneremo sicuri, e a mio giudizio/regnare è una degna ambizione, anche sopra l'inferno:/meglio regnare all'inferno che servire in Paradiso."
Torn from Pelorus, or the shatterd side/of thund'ring Etna, whose combustible/and fueled entrails thence conceiving fire,/sublimed with mineral fury, aid the winds,/and leave a singèd bottom all involved/with stench and smoke: such restig found the sole/of unblest feet. Him followed his next mate,/both glorying to have scaped the Stygian flood/as gods, and by their own recovered strenght,/not by the sufferance of supernal power./"Is this the region, this the soil, the clime,"/said then the lost Archangel, "This the seat/that we must change for heav'n, this mournful gloom/for that celestial light? Be it so, since he/who now is sovran can dispose and bid/what shall be right: fardest from him is best,/whom reason hath equaled, force hath made supreme/above his equals. Farewell, happy fields,/where joy for ever dwells! Hail, horrors, hail,/infernal world, ant thou, profundest hell, /receive thy new possessor: one who brings/a mind not to be changed by place or time./The mind is its own place, and in itself/can make a heav'n of hell, a hell of heav'n./What matter where, if I be still the same,/and what I should be, all but less than he/whom tunder hath made greater? Here at least/we shal be free; th'Almighty hath not built/here for this envy, will not drive us hence:/here we may reign secure, and in my choice/to reign is worth ambition, though in hell:/better to reign in hell than serve in heav'n."
In Schiller (http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/06/commento-al-visionario-di-schiller.html), ne "I Masnadieri" (1781):
"Comunque tu sia, Indicibile Eternità,
solo questo mio Io resta fedele... comunque tu sia,
porterò con me solo me stesso.
Le cose esteriori sono solo l'apparenza dell'uomo.
Io sono il mio Cielo e il mio Inferno
(Ich bin mein Himmel und mein Hölle, nel testo originale)
Anche in Goethe, si trova un monologo di Mefistofele, appena apparso di fronte a Faust; Faust è sorpreso, non sa spiegarsi come il demone abbia potuto uscire dall'inferno. Il demone gli spiega che non è uscito dall'inferno: è ancora all'inferno. Faust, sempre più sconvolto, gli chiede "com'è possibile, io ti vedo, sei qui davanti a me, non sei all'inferno. Ne sei uscito"; Mefistofele gli risponde che è il suo stesso spirito ad essere inferno, ovunque vada e andrà, è il suo spirito il suo inferno.
I miei passaggi preferiti, presi da "Manfredi"
Manfredi: Ora dunque: spiriti aerei e terrestri, non mi sfuggirete; per un potere più oscuro di ogni altro già evocato, per la tirannia di uno scongiuro mi fu luogo natale un astro dannato, infuocato relitto di un mondo demolito, Inferno vagabondo nello spazio eterno: per l'alta maledizione che sta sopra la mia anima, il pensiero che mi sta dentro ed attorno, io vi costringo al mio volere: apparite!
Sesto Spirito: Mia dimora è l'Ombra della Notte: perché la tragica Luce mi sevizia?
Quando la Luna splende sull'onde,
la lucciola tra l'erba,
la meteora sulle tombe,
e il fuoco fatuo sopra la palude.
Quando guizzano le stelle cadenti,
e si rispondono i gemiti dei gufi
e all'ombra della collina silenziosa,
giacciono le foglie,
col suo potere e segno la mia anima sovrasterà la tua.
Anche nel cupo terrore non avrà sonno il tuo Spirito,
tra Ombre inconsumabili pensieri che non puoi esiliare:
per un potere a te ignoto,
non potrai mai essere solo:
avvolti in un Sudario,
stretti in una nube, per sempre abiterai
questo mio incantesimo.
Altra traduzione di questo passo:
Quando la Luna è sull'onda,
e la lucciola nell'erba,
e la meteora sulla tomba,
e lo stormo sopra la palude;
quando le stelle cadenti precipitano,
e stridono i gufi cui l'eco risponde,
e silenziose sono le foglie immobili
nell'ombra della collina,
sarà il mio spirito sopra al tuo,
con un potere e con un segno.
Stupirai che io non ti sia in luogo d'Ombra...
Ascolta: Tu sarai il Tuo Stesso Inferno!
Manfredi: Mi impone la fatalità d'esistere...
Se è vita portarsi dentro questo deserto Spirito
ed essere Sepolcro alla propria anima!
Ribolle la nebbia, sale attorno a ghiacciai:
si levano nuvole, rapide spirali ai miei piedi,
bianche e sulfuree,
schiuma di un'irato Oceano
del profondo Inferno
che scaglia le sue Ombre
su una brulicante spiaggia,
fitta di dannati come ghiaia...
ho le vertigini.
A me idonea Tomba alle mie Ossa placate nell'Abisso.
Manfredi: Evocare i Morti, interrogarli su ciò che noi temiamo. Non vi sarà risposta più atroce della Tomba
e questo è Nulla.
Se non rispondono...
il sepolto profeta rispose alla strega di Endor;
e dall'insonne spettro della fanciulla di Bisanzio
il monarca spartano trasse
una risposta e il suo destino.
Nessun martirio futuro può infliggere a colui che condanna
se medesimo la pena che egli infligge alla propria anima.
Altra traduzione dell'Atto II, scena II
Siamo i giullari del tempo e del terrore; i giorni
si impossessano di noi e ci derubano; malgrado ciò viviamo,
detestando la vita, e ancora temendo di morire.
In tutti i giorni di questo odiato giogo
questo peso vitale sopra il cuore in lotta,
che affonda nel dolore, o batte rapido per una gioia
o una pena che sempre nel languore o in agonia
si chiudono
in tutti i giorni del passato e del futuro, perché
non c'è presente in vita, noi possiamo contare
quanto pochi - quanto meno che pochi - siano
i giorni in cui l'anima
rinuncia a spasimare per la morte; tuttavia essa si ritrae
come da un fiume d'inverno, anche se il gelo
non dura che un attimo. Io ho una risorsa
ancora, nella mia scienza - posso richiamare i morti,
e chieder loro che cosa noi temiamo maggiormente;
la risposta più dura non può che dire: la Tomba,
e questo è nulla. Se essi non rispondono...
Il Profeta sepolto rispose alla Strega
di Endor; e il Monarca Spartano trasse
dallo spirito inquieto della fanciulla Bizantina
una risposta e il suo destino. Egli aveva trucidato
chi più amava, ignorando chi fosse,
e morì senza perdono - pur chiamando in aiuto Giove
protettore dei fuggitivi e a Figalia facendo sorgere
gli Evocatori Arcadi, per costringere
l'ombra indignata a deporre la sua collera,
o a stabilire i termini della sua vendetta. Ed ella rispose
con parole di valore incerto, ma ubbidì.
[...]
Tra qualche ora non chiamerò invano -
tuttavia adesso io temo ciò che oso:
fino a questo momento, mai fuggii lo sguardo
di uno spirito, buono o malvagio - ora tremo,
e sento un gelo strano e freddo sopra al cuore.
Ma io posso fare anche quel che più aborrisco,
e dominare le paure umane - La notte si avvicina.
Atto II, scena III
La luna sorge immensa, piena e luminosa;
e qui sulle nevi, dove mai fu piede umano
dal comune passo mortale, noi avanziamo nottetempo,
e non lasciamo tracce: sopra il selvaggio mare,
l'oceano vitreo del monte di ghiaccio,
noi sfioriamo i taglienti crepacci, che prendono
l'aspetto della schiuma rabbiosa di tempesta,
immobile nel gelo... L'immagine di un gorgo morto:
e questo più erto fantastico pinnacolo,
lavoro di traforo di qualche terremoto - dove le nuvole
sostano per riposare nel passaggio -
è sacro ai nostri incontri ed alle veglie;
qui io attendo le sorelle, sulla via
del castello di Arimane, perché questa notte
è la nostra grande festa - è strano che ancora non vengano.
Atto III, scena IV
Ricordo bene che una volta, in gioventù,
quando me ne andavo per il mondo, - in una notte come questa
stavo tra le mura del Colosseo,
in mezzo ai grandi resti della potente Roma.
Gli alberi che crescevano lungo gli archi spezzati
oscillavano oscuramente nell'azzurro cupo della notte,
e le stelle splendevano tra gli squarci delle rovine;
di lontano un cane da guardia latrava oltre il Tevere:
e, più vicino, dal palazzo dei Cesari, veniva
il lungo lamento del gufo e, a tratti,
il canto inquieto di lontane sentinelle
sorgeva e si smorzava sul vento leggero.
Dei cipressi, oltre la breccia ròsa dal tempo,
apparivano a orlare l'orizzonte, e tuttavia si ergevano
entro un tiro d'arco. Dove i Cesari vissero,
e rauchi vivono gli uccelli della notte,
in una macchia che spunta tra i bastioni diroccati
e intreccia le radici con le dimore imperiali,
l'edera usurpa il campo al lauro.
[...]
COMMENTO AL "CAINO"
Nella feconda estate del 1821 Byron mette mano alla tragedia "Caino" ("Cain") un'azione drammatica in cinque atti, in versi endecasillabi sciolti, che prende le mosse dal racconto biblico delle prime origini dell'umanità.
Sono passati molti anni dalla cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden; la coppia vive nel suo esilio, espiando il proprio fallo con fatiche e dolori e sapendosi condannata a morire. Genitori e Abele accettano con rassegnazione questo fatto, ma Caino no. Caino è un ribelle: rifiuta di prendere parte alle preghiere e ai sacrifici dei familiari. Non domanda nulla al Creatore. Non lo ringrazia; scruta angosciato il mistero della vita e della morte, rimprovera ai genitori di non avere portato a fondo il proprio peccato, conquistando il frutto della conoscenza. L'unica dolcezza della sua vita è rappresentata dalla sposa-sorella Ada. Un giorno gli appare Lucifero, che si qualifica "Signore degli Spiriti" e gli mostra i regni misteriosi della morte, popolati da fantasmi di antichi mondi, preesistiti al nostro, abitati da esseri razionali, molto più intelligenti dell'uomo. Queste visioni destano nel cuore di Caino il senso della propria nullità: ed in questo, sottolinea Lucifero, che consiste la somma dell'umano sapere.
"Trasmetti ai tuoi figli in retaggio tale conoscenza: essa risparmierà loro molti tormenti".
Di pari passo egli cerca di instillare nel giovane il disprezzo per il legame amoroso, rappresentato da Ada, e l'insofferenza per Abele, che la madre predilige e che Dio ama; l'eco delle parole di Lucifero rimane nel suo spirito, colmandolo di ribellione e di amarezza. Il "Principe delle Tenebre" lo ha in un certo modo rivelato a se stesso, dando una voce a un fondamento di acute argomentazioni a quanto sinora non era altro che un oscuro e inarticolato senso di ingiustizia patita, diffuso in lui. Quando Abele lo esorta a offrire a Dio i sacrifici di rito, Caino acconsente, dopo un'aspra discussione, ma la sua offerta è una sfida e una bestemmia: egli non crede alla bontà del Creatore, a cui rinfaccia i mali dell'umanità, e nemmeno crede di migliorarsi "piegando le ginocchia". Un turbine di vento, segno dell'ira divina, sconvolge il suo altare, ma Caino non si placa: dichiara che non offrirà più sacrifici e che abbatterà lo stesso altare del fratello, dove è stato versato il sangue di vittime innocenti ("Abbattere quell'abbietto adulatore delle nuvole, il fumoso precursore delle tue ottuse preghiere, il tuo altare, col suo sangue di agnelli e di capretti che furono nutriti di latte per essere distrutti nel sangue"). Invano Abele lo scongiura e si frappone fra lui e l'altare ("Fratello, retrocedi! Tu non toccherai il mio altare con la violenza"): l'ira di Caino si abbatte su di lui ("Allora rendi la tua vita al tuo Dio, una volta che egli ama le vite"). Davanti alla morte che il suo braccio ha portato sulla terra, l'omicida prova una crisi di dolore, di rimorso ("La mia mano! è tutta rossa, e di... di che?" "Fratello mio svegliati! Perché giaci a quel modo sulla terra verde!", "è sangue, il mio sangue, di mio fratello e mio; e versato da me!"). Se ne andrà disperato e ramingo, segnato in fronte dal marchio dell'Angelo del Signore.
Questo dramma dall'impalcatura grandiosa, di una cupa e corrucciata potenza, è quello che più di tutte le opere di Byron consolidò "la sua fama satanica". Nonostante le lodi di Goethe, di Shelley, di Walter Scott, il pubblico gridava allo scandalo, rimproverando a Byron d'aver esaltato l'empietà di Caino e la ribellione di Lucifero senza dare adeguato risalto al valore morale degli altri personaggi.
Nel 1822, l'Alta Corte di Giustizia negò all'editore i diritti di proprietà letteraria sul "Caino", "trattandosi di opera diretta a schernire e screditare la Sacra Scrittura"; la sentenza ottenne l'effetto opposto a quello che si proponeva: tolto il copyright, le edizioni "pirata" si moltiplicarono, contribuendo alla diffusione dell'opera.
Il ghigno dei satanici
Una strettissima parentela lega tra loro gli eroi di tre dei quattro "Racconti Orientali". Ma il conte Lara, il corsaro Conrad e Giaurro sono usciti dalla medesima matrice, improntati al più puro "satanismo romantico", e destinati ad avere una larga proliferazione nel cinquantennio seguente. Una cupa fatalità accompagna questi personaggi: la loro bellezza è sinistra, il loro sorriso è un sogghigno, il loro amore apportatore di sventura, per tutti vi è il peso di segreti sepolti nel passato. La solitudine di cui questi cupi eroi sono prigionieri e la loro incapacità di sentirsi parte del consorzio umano, non sono che la proiezione letteraria della fiera misantropia di cui Byron si era fatto una specie di armatura spirituale nella giovinezza e che depose in seguito.
La figura del ribelle a Dio costituisce un motivo ricorrente nell'opera di Byron: quasi il riflesso di un'idea ossessiva che egli portò con sé fin dagli anni giovanili e che affondava le radici nelle regioni misteriose dell'inconscio. La sua educazione rigidamente calvinistica aveva instillato nel poeta il concetto di un Dio tirannico; gli era stata insegnata la feroce dottrina della predestinazione, secondo la quale la sorte eterna dell'uomo, salvezza o dannazione, è già stata stabilita prima che venga al mondo. (*) Da questo complesso di credenze Byron non era mai riuscito a svincolarsi completamente: avvertiva in sé il tumulto delle passioni e lo scambiava per il segno di una fatale e inevitabile condanna: il marchio di Caino. Donde la sua ribellione. Nella tragedia intitolata al primo reprobo dell'umanità, il poeta presta la sua voce alle rivendicazioni di Caino, che è un personaggio che pensa e pone angosciosi interrogativi; è un solitario e un incompreso; non capisce come ci si possa adattare, rifiuta il dono della vita visto che "gli sarà tolto" e non ha chiesto di nascere, né si sente corresponsabile dello sbaglio dei genitori. Lucifero, accanto a lui, non fa opera di tentatore, ma si limita a rivelargli il fondo stesso dei suoi pensieri: "Io non tento alcuno, se non con il vero", ossia mettendo una persona di fronte a se stessa. Anche il fratricidio non è tanto compiuto contro Abele, ma contro Dio: Caino si proponeva di rovesciare l'altare del fratello, ancora fumante del sangue di animali innocenti e di rinnegare così la Divinità che gradiva simili sacrifici.
Quanto all'altro ribelle, Lucifero, è evidente che nel delinearne la figura, Byron ha sentito l'influsso del Satana di Milton.
Dal punto di vista artistico, il Satana del "Paradiso Perduto" è più grandioso, e specie nei primi canti ha qualcosa di titanico nella disperazione e nella sfida. L'arcangelo caduto di Byron è una creazione meno possente e più sottile: in esso aleggia qualcosa del Mefistofele di Goethe. è un ragionatore e un filosofo: la sua conquista di Caino avviene attraverso una rete di capziosi argomenti, di dimostrazioni dall'apparenza ineccepibile. Il suo sarcasmo è spesso bruciante. Come il Satana miltoniano (**) esita, per fierezza, a calarsi nel corpo vile del serpente, così il Lucifero di Byron rinnega ogni parentela con l'antico tentatore e sostiene che si tratta di un vero serpente. Nel Lucifero di Byron, inoltre, non si ravvede più un odio selvaggio per l'uomo, ora che l'umanità è caduta.
(*) APPROFONDIMENTO SULLA "PREDESTINAZIONE": http://giacintobutindaro.org/2014/01/09/due-destini-diversi/
http://giacintobutindaro.org/2013/11/13/coloro-che-dio-cancellera-dal-libro-della-vita/
(**) Un breve commento al Satana di Milton di Attilio Siro Nulli
"L'antitesi irriducibile Dio-Satana torna ad essere il motivo ispiratore del "Paradiso Perduto", di John Milton (1608-1674). Satana, l'angelo ribelle, precipita assieme a quelli che l'hanno voluto seguire nel caos, ma non si arrende. Ha udito in cielo una profezia a proposito della creazione di un nuovo mondo, la Terra, e di un essere, l'Uomo, e decide di saperne di più. Da qui prende il via una serie di eventi drammatici: il Figlio offre se stesso per la salvezza dell'umanità, destinata a essere tentata e pervertita dal Demonio. Satana assume la forma di angelo minore e penetra, tra dubbi e timori, nell'Eden; Eva viene tentata una prima volta da Satana perché mangi il frutto della scienza nonostante la proibizione divina, ma interviene l'arcangelo Raffaele e racconta la storia della battaglia fra angeli buoni e angeli ribelli... Ma Satana non demorde. Tornato al Cielo, l'arcangelo ritorna nell'Eden sotto forma di nebbia, si insinua nel serpente, e si avvicina nuovamente a Eva. Blandendola scaltramente, la induce a mangiare il frutto proibito, e ad offrirlo ad Adamo. Dio allora pronunzia una servera condanna contro la prima coppia, che scaccia dal Paradiso terrestre. La Morte e la Colpa, incoraggiate dal successo di Satana, decidono di salire nel mondo abitato dall'uomo, ma l'arcangelo Michele predice l'incarnazione, la morte e la resurrezione del Figlio di Dio per la salvezza dell'umanità. La partita ora si gioca sulle virtù teologali della Fede e della Speranza, ma le porte del Paradiso terrestre si sono chiuse per sempre, e una schiera di cherubini si pone alla guardia del divino giardino.
Con Milton, suo malgrado, Satana assume definitivamente un aspetto di bellezza irrimediabilmente decaduta, e, quindi, di inconsolabile nostalgia. (già il titolo del Poema è estremamente significativo). Solo chi ha rivestito questa bellezza fulgente può amaramente rimpiangerla e dare, nel suo non arrendersi, una potente caratterizzazione del Male, che è come dire della disperazione. Un Lucifero come quello di Dante, ficcato immobile in mezzo alla terra, non può ricevere un aspetto epico, ma se un poeta sviluppa il mito di Lucifero come protagonista di una poema solenne, la figura stessa del Diavolo deve necessariamente assurgere all'altezza dell'Epica: così Milton alla fine nobilita il suo Satana-Lucifero con la Grandiosità stessa del compito che gli fa assumere, e la serietà con la quale egli cerca di condurlo a effetto."
COMMENTO AL GIAURRO E AL CORSARO
Tra il 1813 e 1814 esce il gruppo dei "Racconti Orientali", novelle in versi che comprende "Il corsaro", "Il giaurro", "Lara", "La sposa di Abido".
"Il corsaro" è composto da tre canti, in versi endecasillabi, a rima baciata. Protagonista della storia è un misteriosissimo Conrad (o Corrado) temibile pirata, flagello dei galeoni turchi carichi di ricchezze. Di lui si sa soltanto che per i torti ricevuti in gioventù odia il genere umano. I suoi uomini lo seguono ciecamente nei più rischiosi assalti, tuttavia un muro lo separa da loro; non partecipa ai banchetti, non beve per celebrare la vittoria, nessuno l'ha mai veduto sorridere. Vi è tuttavia un lato vulnerabile: il tenero vincolo d'amore che lo lega alla sposa, Medora.
All'aprirsi del poemetto, siamo nell'isola inaccessibile che serve ai pirati da quartier generale, dove vive anche la gentile Medora. Un messaggero svela a Conrad l'intenzione de pascià Sayd di organizzare un attacco contro la tana dei corsari, per distruggerla. Egli decide allora, benchè inferiore assai di forze, di prevenire il nemico con un colpo di mano. Sulle prime, sgominati dalla sorpresa, i Turchi hanno la peggio. Gli uomini di Conrad, ubriachi di vittoria, forzano le porte dell'harem e si abbandonerebbero ai peggiori istinti se il capo non intervenisse. La favorita dell'harem, la bellissima Gulnare, riceve la sua cavalleresca protezione. Tuttavia, mentre i pirati indugiano nel Serraglio, i Turchi si riorganizzano e tornano all'attacco. In breve le sorti della battaglia si capovolgono e Conrad cade prigioniero. Il pascià lo destina ad una morte atroce ma Gulnare, memore della generosità di lui, decide di salvarlo e uccide Seyd nel sonno, fuggendo poi con il corsaro e rivelandogli il suo amore. Ma Conrad, fedele a Medora, non può ricambiarla: le concede soltanto un bacio. Quando il vascello fuggiasco approda finalmente all'isola dei corsari, una scena luttuosa si presenta agli occhi di Conrad: la sposa non ha resistito alla notizia della sua cattura e gli giace davanti, bellissima ma pallida e senza vita.
Nella notte, il corsaro scompare. Se abbia cercato nel profondo mare l'oblio o sia fuggito a nascondere il suo dolore in luoghi remoti non si saprà mai.
Il Giaurro riprende la storia turca degli amori di un veneziano e di una schiava del Serraglio di un ricco musulmano; scoperta l'infedeltà di lei, lo spietato padrone la fece mettere a morte secondo il costume islamico, chiusa in un sacco e precipitata nel mare. Il Giaurro è "il cristiano" secondo la dizione musulmana, innamorato di Leila, schiava dell'emiro Hassan. Dopo l'orrenda morte di Leila, il Giaurro e l'emiro si ritrovano in battaglia: si assalgono con furore, e il cristiano abbatte il rivale. Ma nemmeno il sangue placa il Giaurro. Solitario e cupo, lo ritroviamo in un convento e la sua presenza incute un arcano terrore ai confratelli; finché una fossa senza nome accoglierà il suo cadavere.
Una breve citazione anche per gli altri racconti:
nel poemetto "Lara" c'è una sorta di seguito di "il corsaro": il conte Lara che vive solitario, accompagnato da un paggio devoto, si rivelerà essere Conrad (seguito da Gulnare, travestita da paggio); in "La sposa di Abido", Selim, figlio negletto del pascià Giaffir, ama la sorellastra Zuleica, destinata in sposa ad un uomo crudele.
Per quanto riguarda la novella "Parisina", mi limito a riportarla in sintesi. è una delle ultime opere composte prima dell'esilio; il soggetto è tratto dalle "Memorie per la storia di Ferrara" di Antonio Frizzi e da una novella di Matteo Bandello. Si tratta di una fosca storia d'amore e di morte, ambientata nel Rinascimento Italiano. Il marchese di Ferrara, Niccolo III d'Este (nel poema di Byron, chiamato Azzo), scopre l'adulterio tra Ugo, suo figlio illegittimo, e Parisina Malatesta, sua moglie. I due vengono gettati nelle segrete del castello e poi decapitati, ma Byron reinterpreta la morte di Parisina: la scoperta del suo adulterio avviene nel segreto della camera nuziale, dove Parisina, reduce da un convegno con Ugo, mormora nel sonno il nome di lui. Accertata la colpa dei due, all'indomani Ugo viene decapitato mentre Parisina dovrà mirarne la testa mozza.
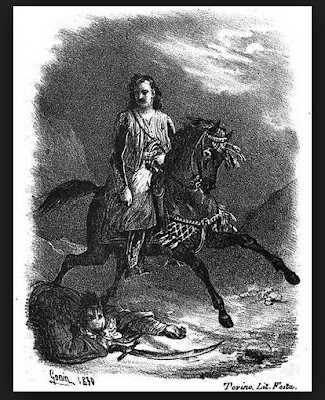 |
| Giaurro |
 |
| Parisina |
COMMENTO ALL'AROLDO
"Il pellegrinaggio di Aroldo il Cavaliere" ("Childe Harold's Pilgrimage) è un poema in quattro canti che narra i viaggi di un immaginario cavaliere medioevale, Aroldo, seguendo passo passo gli itinerari percorsi dal poeta stesso. Byron negò sempre qualsiasi identificazione fra lui e il personaggio di Aroldo, ma il pubblico non si lasciò trarre in inganno, tanto più che in un primo tempo il protagonista del poema avrebbe dovuto chiamarsi col nome ancestrale dei Byron in epoca medioevale: Childe Burun.
Anche il medievalismo di maniera è poco più che un pretesto, e non tarda ad essere messo da parte. Nel primo canto la cornice medievale ha una certa consistenza: il linguaggio vi si intona, con l'uso di termini arcaici e ormai desueti. Ma ben presto non appena il viaggio vero e proprio ha inizio, la realtà contemporanea prende il sopravvento: il vero pellegrino è George Gordon Byron e l'epoca è il tormentoso secondo decennio dell'Ottocento.
Il primo canto narra il viaggio di Aroldo attraverso il Portogallo e la Spagna; il tono è sovente disuguale; ad imitazione dell'Ariosto, di cui si professava grande ammiratore, Byron mescola il leggero con il solenne, la commozione con l'ironia: ad esempio dopo aver descritto con estatici tocchi lo splendore di Lisbona "che rilucendo di lungi, appare celestiale", passa a descrivere con crudo verismo la sporcizia dei suoi abitanti. Pagine celebri sono dedicate alle sanguinose memorie che evocano i campi di Albuera e di Talavera, alla bellezza di Siviglia, alla dolce vita di Cadice. Non manca uno spettacolo di Corrida. Col secondo canto si entra in Grecia. Pagine di rovente ironia bollano l'archeologo predone Lord Elgin, che, ambasciatore presso la Sublime Porta nel 1799, rapì alla Grecia un ingente numero di reliquie, tra cui il fregio del Partenone. Aroldo tuttavia lascia la Grecia senza un sospiro. Strofe piene d'incanto celebrano la bellezza dei viaggi marini, la notte sul Mediterraneo, le Isole Ionie, vere dimore di Calipso. Passa a vela davanti all'Albania, saluta la rupe di Leucade, sacra alla memoria di Saffo, s'avventura nel cuore delle valli illiriche. Oltre lo squallido Pindo e il lago d'Acherusia, giunge alla monastica Zitza, contempla i confini dell'Epiro e i minareti di Telepeni; è accolto nella dimora del gran capo locale (il Bey Alì, che già ricevette Byron). Un inno finale auspica la resurrezione della Grecia. Il contrasto romantico fra la bellezza della natura perennemente giovane e le maestose rovine del passato, come pure fra la grandezza dell'età remote e la miseria politica è un tema caro a Byron che lo riprende con accenti più profondi a proposito dell'Italia. Anche questa seconda parte termina fra pensieri di morte.
Il terzo e quarto canto sono in realtà due poemetti a se stanti: ben poco hanno in comune con l'Aroldo prima maniera. Nel terzo canto è evidente l'influsso delle idee di Shelley e Wordsworth: il testo è improntato ad un panteismo che esalta i legami fra l'uomo e la Natura e vagheggia un amore universale. Il personaggio Aroldo riappare, "torturato da ferite che non uccidono ma non si rimarginano" e tosto si rigetta nei viaggi perché ha in uggia le dimore degli uomini. Esule volentario, egli va ramingo: a Waterloo sulla tomba dell'Impero; lungo il Reno fra i castelli disabitati, spettri come i loro antichi padroni; in vista delle Alpi colorate di neve; presso il lago Lemano "dal volto cristallino".
Del tutto diversa è l'intonazione del quarto canto. Il momento panteistico è superato, la sua filosofia è filosofia d'azione, che si esprime in odio della tirannide (come Alfieri, nota di Lunaria http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/vittorio-alfieri-vita-e-commento-alla.html ); sono i motivi che lo avevano reso caro ai patrioti del nostro Risorgimento. Il poemetto si apre a Venezia, sul Ponte dei Sospiri; poi il lettore viene condotto ad Arquà, tomba del Petrarca, a Ferrara tra le ombre dei poeti della corte estense; a Firenze, l'Atene etrusca; quindi al Trasimeno, alle fonti del Clitunno, alla cascate del Velino e infine Roma. Dovunque è il senso della caducità umana, il contrasto tra le glorie del passato e lo squallore del presente.
Lord Byron diciannovenne, nelle vesti di Aroldo, si imbarca per il continente
"Io rivesto me stesso del personaggio che sto creando, ma solo fino al momento in cui stacco la penna dal foglio di carta" (Byron, 1822)
è stato detto con insistenza, a proposito dei personaggi byroniani, che essi non sono se non proiezioni della personalità dell'autore. In verità questa osservazione è applicabile a tutti i poeti romantici, nel senso che l'elemento soggettivo è sempre dominante nelle loro opere.
Aroldo, il più celebre degli eroi di Byron, - così celebre che fin dalla sua comparsa il pubblico, nonostante le smentite, si ostinò a vedere un travestimento dell'autore - è un'immagine di Byron quale era nei momenti di meditazione e di malinconia che si alternavano in lui alle crisi di dissipazione e all'ardore di vivere. Infatti Aroldo, nonostante la posticcia cornice medioevale, è una figura tipica del primo Ottocento: un esempio di quella "generazione perduta" che allevata in epoca rivoluzionaria e napoleonica, si trovò a vivere il clima della Restaurazione.
La malinconia di Aroldo nasce dal continuo e stridente contrasto fra l'ideale e il reale, dalla coscienza dell'abisso invalicabile che si apre fra le aspirazioni dell'animo e le risposte della vita. Aroldo è sostanzialmente un essere deluso: ha percorso "tutto il lungo labirinto del peccato" e non ne ha raccolto che sazietà e noia; il suo proclamarsi un'anima solitaria non nasce dal disprezzo della società, ma piuttosto dal vagheggiare un ideale di amicizia troppo alto perché uomini o donne possano accostarvisi. Il viaggio di Aroldo in cerca di un cambiamento (mentre ciò che vorrebbe sarebbe cambiare se stesso) diventa per lui una serie d'occasioni per proiettare l'intima sua malinconia su alcuni tra i paesaggi più superbi del mondo e di farli partecipi delle sue emozioni. Così, di strofa in strofa, di canto in canto, si inseguono gli aneliti all'ideale e gli urti determinati dal contatto con la realtà. Anche la visione delle rovine di passate grandezze - la Grecia, l'Italia - suggerisce malinconici confronti con la miseria del presente, e il senso della vanità d'ogni cosa umana si accentua nello spirito di pellegrino. Solo raramente, attraverso la comunione con la Natura, è raggiunta una sorta d'illusoria tregua; ma ben presto l'inquietudine e la ricerca riprendono poiché, per ammissione del protagonista, "la quiete è un inferno per i cuori ardenti... O Amore! Tu non sei un abitante della Terra.... O Stelle, che siete la poesia del cielo, se nel vostro splendore potessimo leggere i destini di uomini e di imperi..."
Approfondimenti: https://deisepolcriecimiteri.blogspot.com/2022/02/byron-e-il-male.html http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/09/byron-e-la-morte-di-shelley.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/milano-vista-da-shelley-byron-ed-edith.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/george-byron-i-versi-piu-belli-e-i.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/11/byron-ma-prima-inviata-sulla-terra-in.html